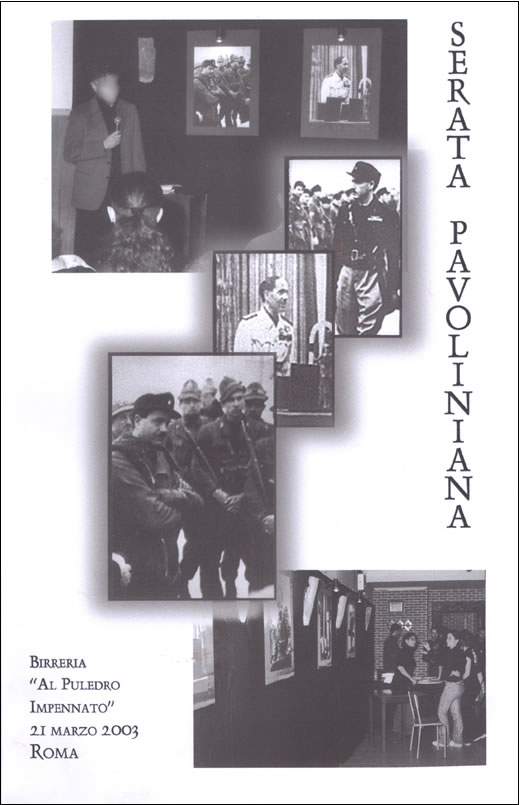“Un’Idea vive nella sua pienezza
e si collauda nella sua profondità quando il morire battendosi per
essa non è metaforico giuramento ma pratica quotidiana”.
Parole secche, prive di retorica
perché già pregne di lucido pathos; non parole al vento,
perché dette da colui che rese usuale, quotidiano, normale, il gioioso
martirio di stampo squadrista, perché pronunciate da colui che avrebbe
combattuto fino all’ultima cartuccia, che avrebbe creduto al Ridotto della
Valtellina - le famose Termopili del Fascismo - e avrebbe infine comandato
di fatto il suo stesso plotone d’esecuzione.
Questo, signori, è Pavolini
e potremmo fermarci qui.
Potremmo fermarci qui perché
l’essenza non necessita di fronzoli, di ragionamenti, di elucubrazioni.
Ma l’uomo seduto, distratto, risucchiato nella spirale di un vivacchiar
banale cerca spiegazioni, cerca ragionamenti, cerca conferme, quasi a voler
esorcizzare in qualche modo la nuda verità che recita così:
o si hanno le palle o si è buffoni.
E poiché a nessuno piace
ammettere di essere un buffone ecco che la virilità se la cuce addosso,
se la costruisce esorcizzando il dramma e la tragedia con ragionamenti
cha sembrano limpidi e coinvolgenti e che spiegano il come ed il perché,
che anatomizzano la storia togliendole ogni afflato, rendendoci incomprensibile
chi invece è quanto mai chiaro, da Attilio Regolo a Pietro Micca,
da Giovanni dalle Bande Nere a Che Guevara (ucciso una seconda volta dai
suoi che ne han fatto un simbolo di marchandising).
Ed allora, signori, perdiamoci nella
ragnatela dei ragionamenti ed andiamo a vedere come si esprime l’uomo-mito
o il mito-uomo Alessandro Pavolini che uomo fu dei più eccezionali
e mito è in tutto e per tutto.
E per la sua eccelsa figura e perché
“Miuthos” per i nostri antenati significava “discorso del verbo” ossia
rappresentava uno dei modelli compiuti, logici e dunque razionali attraverso
i quali l’essenza propone se stessa e la via per essere finalmente colta.
Mito è, dunque, un modello eterno, incarnato da un tipo originario
(l’Archetipo) che segue una strada che già è stata percorsa
e che il medesimo tipo dovrà percorrere sempre, nell’ atemporale
eterno ritorno.
Mito è tragedia, ovvero annullamento
dell’individualità costruita, nel recupero della natura elementare
e nel collegamento folgorante e devastante con il Divino.
Alessandro Pavolini è dunque
Mito, completamente e senza la necessità di costruzioni teoriche.
È talmente mito che, vuoi
per rispetto, vuoi per timor reverenziale, vuoi per vergogna di operare
il confronto, vuoi per giustificare accomodamenti e cedimenti interiori,
gli stessi sopravvissuti alla tragedia di quegli anni han pensato bene
di parlarne poco. Bene han fatto perché la retorica e le esternazioni
aderiscono assai meglio a chi non ha raggiunto l’essenza nuda che non a
chi ci sovrasta e ci accompagna silente con quell’ironico e tagliente sguardo
che altro non è se non la nostra stessa coscienza. Grande parola
troppo spesso utilizzata a sproposito…
Alessandro Pavolini stupì
tutti. Stupì la Firenze bene, i salotti degli intellettuali, il
suo amico Galeazzo Ciano, il suo conoscente Indro Montanelli. Li stupì
talmente da indurli a vaneggiare che ce ne fossero due. Un Pavolini moderato,
letterato, illuminato, indulgente verso i critici del Regime ed un Pavolini
sconvolto dal tradimento del 25 luglio; sconvolto a tal punto da cambiar
carattere, da divenir brutale, intransigente, selvaggio ed esaltato.
È la mistificazione prima
e forse la più importante: è l’operazione di autogiustificazione
da transfert psicologico tramite il quale i deboli ed i vili s’innalzano,
o meglio evitano di sprofondare, rifiutando il confronto. Non vi furono
due Pavolini, la demonizzazione o meglio ancora le giustificazioni psicotiche
atte ad esorcizzare quello del secondo corso tradiscono una precisa volontà:
attribuire a passione scomposta, a ragione sconvolta, la disposizione ferma
e continua ad essere se stessi senza flettere, pagandone qualsiasi costo.
La coscienza borghese (una parola
usata a sproposito, dicevamo), questa finta coscienza recita così:
esprimi una fede e recita il copione ma non andare mai oltre, questa fede
e questa coscienza sono infatti una veste, un fatto estetico, non prenderle
sul serio, mai.
Di gente così, quattro secoli
fa, si disse che erano “disposti a difendere le loro opinioni fino al rogo
escluso…” E probabilmente i suoi contemporanei amici di salotto s’inventarono
anch’essi due Giordano Bruno: affinché il suo ricordo non li schiacciasse.
Questi buoni borghesi dovevano -
e tuttora devono - credere che solo uno stupido, un rozzo, un ottuso, un
selvaggio possa andare incontro al sacrificio, possa non aver il genio
di evitare il conflitto, di venir meno alle sue responsabilità,
di scegliere la tragedia ripudiando la farsa.
E come accettare che il più
illuminato ministro della Cultura, il più liberale (come indole
ovviamente) federale di Firenze e forse d’Italia, l’indulgente frequentatore
dell’intelligentia antifascista, fratelli Rosselli inclusi, il figlio del
più illustre professore di Sanscrito, il miglior conoscitore delle
tradizioni scandinave, l’ideatore ed il realizzatore dei Littoriali della
Cultura che avrebbero consacrato gente come Fermi, Blasetti e Fanfani,
l’uomo che salvava le opere di Visconti dalla censura di Regime, il personaggio
forse più intelligente, colto e sensibile del Ventennio dunque,
abbia accettato la sfida, abbia fatto fronte alla disfatta, abbia fondato
il Partito Combattente e le Brigate Nere, abbia operato una vera e propria
rivoluzione culturale, antropologica e sociale e sia andato a morire serenamente
e consapevolmente ? Per nulla secondo la morale borghese, per tutto secondo
lo spirito nudo, essenziale ed esaltante della Civiltà.
Lo definirono allora esaltato (mentre
al contrario esaltava), cioè sprovveduto, folle, posseduto, maniacale
e si lavarono le mani del suo sangue. Che non era il loro ma è certamente
il nostro.
Poeta e scrittore, Pavolini ebbe
la vocazione al giornalismo fin dall’età di otto anni (quando produsse
autonomamente il periodico bellicista “La Guerra”), al quale fece seguito
“Il Buzzecolo”; durante il Fascismo, cui, non appena diciottenne, aveva
aderito fin dal 1920, fu il fondatore de “Il Bargello”, poi inviato speciale
e combattente in Abissinia, prima di divenire appunto Ministro della
Cultura e direttore de “Il Messaggero”. Scrisse libri e racconti di altissimo
livello come “Giro d’Italia”, “Nuovo Baltico”, “Tutto il Danubio”, “Cento
metri”, “Il leopardo Dil Dil”, “La Disperata”, “Ritratto d’Angela”.
A Firenze seppe imporsi con buon
senso tra lo squadrismo aggressivo e “plebeo” di Tamburini e quello aristocratico,
esteta e lievemente classista di Perrone Compagni. Di lui si disse che
era un “fascista equilibrato” ed un “protettore delle arti”. Ideò
il Maggio Musicale, la Partita di Calcio in Costume, la Mostra dell’Artigianato
al Ponte Vecchio, le Rassegne d’Arte, la Fiera del Libro, la Primavera
Fiorentina, il Teatro Sperimentale dei Gruppi Universitari Fascisti e i
Littoriali della Cultura.
Da Federale approvò i progetti
e determinò la realizzazione dello Stadio Comunale, della nuova
Stazione di Santa Maria Novella e dell’Autostrada Firenze-Mare. Contribuì
all’allargamento dell’edilizia popolare. Sin dal 1934 fu deputato alla
Camera dei Fasci e delle Corporazioni.
Nel 1939 diviene ministro della
cultura e coglie subito l’importanza della Radio e del Cinema. È
temuto dai Tedeschi che lo considerano un “moderato” ma è tenuto
in grande considerazione da Joseph Gobbels, il plenipotenziario del Terzo
Reich che s’intende parecchio sia di propaganda che di uomini.
Nel febbraio del 43, a causa di
un cambio della guardia, è rimosso dal dicastero. Al momento del
colpo di Stato del 25 e 26 luglio Pavolini ha così tutte le carte
in regola per uscire indenne dalla bufera.
Ha alle spalle una tradizione di
buon governo e frequentazioni antifasciste che lo garantiscono. Dai fratelli
Rosselli, ad Alberto Carocci, Arturo Loria, Gaetano Salvemini, Piero Gobetti
e Jean Luchaire. Ha frequentazioni ebraiche; è il miglior amico
del ribelle Ciano. È ricco di famiglia ed ha un passato così
illustre, pur non essendo ancora quarantenne, da non necessitare di alcuna
ambizione supplementare. I Tedeschi lo considerano un “moderato”; per molto
meno centinaia di individui si sono costruiti un passato da “resistenti”
ed hanno attraversato indenni il guado.
Indenni fisicamente ma non moralmente.
Pavolini invece passa il Rubicone.
“Al mitra ! Alla macchia !” è il suo grido di reazione. Organizza
subito con altri camerati la risposta fascista. La notte dell’8 settembre
da un binario morto di Koenigsberg parla al popolo italiano insieme a Vittorio
Mussolini. Il 14 settembre è a Monaco ad accogliere il Duce liberato
da Skorzeny e da Student. Resterà con lui fino all’ultimo e sarà
assassinato lo stesso giorno a pochissimi chilometri di distanza.
L’uomo di cultura, colui che da sempre
ha preteso che azione e pensiero sono inscindibili, dà allora il
senso pieno a questo termine che con l’andare del tempo e soprattutto del
decadimento, noi abbiamo svalutato e svilito ma che significa invece adesione
piena di ogni atto ad un modello ideale. Kultur in tedesco non a caso vuol
dire Civiltà.
Pavolini incarna il binomio inscindibile
della retorica ventennale “libro e moschetto” e si fa, o meglio si conferma
pienamente e senza esitazioni, “poeta armato”.
Il Duce lo fa segretario del nascente
Partito Fascista Repubblicano, ovvero lo innalza alla seconda carica della
Repubblica Sociale e gli dà il compito di organizzare e di rifondare
al contempo il Partito.
Deve farlo in una coabitazione burrascosa
con i vertici dell’Esercito, con la corrente legalista e reazionaria, dovendo
fare ogni giorno i conti con il controllo sospettoso dello Stato Maggiore
Germanico. Deve farlo partendo da zero. E Pavolini non ha dubbi “Camerati
si ricomincia. Siamo gli stessi del 21”.
Azzerare significa andare all’essenziale.
Ovvero rifiutare la tessera del
Partito a chi non sia disposto a sacrificarsi quotidianamente; ragion per
cui il nuovo Segretario ottiene che sia concesso ai non iscritti
di ricoprire incarichi statali e pubblici perché l’iscrizione non
deve essere una formalità burocratica ma la firma cosciente della
propria condanna a morte. Idealista si ma realista come nessun altro egli
difatti non si fa illusioni sull’esito della guerra né sulla sorte
che è riservata a chi non piegherà la testa.
Il suo primo atto, simbolico ma
concreto, è quello di militarizzare la sede romana del Partito mettendo
alla sua guardia i giovani volontari di Bir el Gobi, tra i quali sceglierà
il suo attendente, Enzo De Benedictis.
La sua rifondazione è totale
e non lascia adito ad equivoci.
Il Fascismo repubblicano è
irredentista, nasce, cioè, sul mito risorgimentale ma persegue un
nazionalismo universalista a forte impronta europeista.
Il Fascismo repubblicano intende
combattere tutte le internazionali del potere.Quelle economiche, finanziarie,
religiose e politiche. Per farlo si deve partire dal centro, ovvero dalla
formazione di un uomo che sia soggetto rivoluzionario. Lo stato pavoliniano
intende così plasmare le giovani generazioni, renderle coscienti
delle proprie potenzialità, educarle ad uno scopo, cancellando tutti
i difetti ereditati dall’Italietta liberale e da una certa mentalità
cattolica antinazionale e clericale.
Per modellarsi serve un mito storico
ed etico. Ed ecco che il perno intorno al quale operare viene offerto dall’epopea
rivoluzionaria dello squadrismo.
Sulla base dello squadrismo si effettuerà
la Seconda Rivoluzione e si affermerà la Terza Roma.
Per questo la “Rifondazione” che
si compirà sul “Mito della Marcia” si instaurerà sul rinnovamento
giovanile, sull’istituzione di comitati d’azione e di neo-triumvirati.
Il pragmatismo antiborghese ne sarà il modus pensandi et operandi,
l’humus nel quale formare l’aristocrazia del pensiero/azione azione/pensiero
che garantirà l’ “Unità ideale e operante delle generazioni
passate, presenti e future”.
Da queste premesse emerge naturale
la subordinazione del privato al pubblico con tanto di proprietà
statale dei beni di produzione e di socializzazione intesa più che
a garantire l’equilibrio del Ventennio tra Capitale e Lavoro ad imporre
la prevalenza etica ed economica del secondo sul primo.
Nella tendenza ad accorciare le
distanze tra proletariato e piccola borghesia, Pavolini non è mosso
da fascinazioni proletarie bensì dalla consapevolezza che partecipazione
e produzione sono le due condizioni necessarie per portare un popolo a
divenire padrone di sé.
Il concetto organico di popolo assume
allora centralità, i termini fondanti della Rifondazione sono Nazione
e Popolo, il concetto della loro sintesi è Rivoluzione di Popolo.
La cultura per Pavolini è
azione oltre che pensiero. I richiami ideologici non saranno dunque lettera
morta ma azione quotidiana. Per Pavolini non si deve prima vincere e poi
mutare perché la mutazione è nel combattimento. Egli crede
nella rivoluzione continua.
Tanto per cominciare introduce l’autocritica
e la democrazia diretta nell’apparato del Partito. Le cariche diventano
elettive, le assemblee hanno un ruolo nuovo in un Partito totalitario che
è sì centralizzato ma federale e molto attento al radicamento
territoriale.
Un binomio si pone a garanzia dell’ortodossia
spirituale nell’alveo della rivoluzione continua: è il binomio composto
dagli antichi squadristi accorsi all’appello e dai giovanissimi volontari
di Bir El Gobi, i nuovi squadristi.
Il Partito deve impegnarsi in opere
di beneficenza, in assistenza a chi soffre, ai bisognosi, ai senza tetto,
deve sostituire lo Stato, o meglio i servizi dello Stato, laddove le comunicazioni
belliche lo vedono latitare, ma non deve in alcun caso compiere azioni
di polizia.
La solidarietà, la generosità
e l’impersonalità nel servizio sono le parole d’ordine dell’azione
pavoliniana. Il PFR giungerà così ad esprimere leggi giuste
e rivoluzionarie quali l’abolizione delle società anonime e azionarie
e a delegittimare giuridicamente il concetto di padrone-proprietario.
Nel Fascismo repubblicano trovano
piena espressione le idee socialrivoluzionarie di Bianchi, Sorel e Corridoni,
ed anche la tradizione storico-ideologica di Garibaldi e Pisacane.
Il Partito in guerra deve essere
partito armato, deve essere Milizia rivoluzionata. Così dopo un
lungo insistere, nel giugno del ’44 Pavolini otterrà la costituzione
delle Brigate Nere.
Alle quali non si aderisce in quanto
militanti del PFR ma, da militanti del PFR, per aderirvi, si deve fare
domanda volontaria.
“Chi siete io non lo so; chi siamo
ve lo dirò: siam le Brigate Nere e abbiam la forza di spezzarvi
il cuor !”
Al di là della sinistra iconografia
che
ne han fatto gli avversari di fuori (i partigiani) e soprattutto gli avversari
di dentro (quelli del “fino al rogo escluso”) le Brigate Nere rappresentano
un fenomeno autenticamente rivoluzionario e, tanto per non guastare, di
nutrito consenso.
Quando la proposta pavoliniana di
armare il Partito viene accolta, nell’estate del 44, gli esiti bellici
sono evidenti, la Capitale è perduta, del resto vergognosamente
perché non si è difesa. L’esercito dell’Onore non ha più
lo stesso entusiasmo di pochi mesi prima, le truppe non hanno il morale
alle stelle. Il decreto mussoliniano consente non solo l’istituzione delle
Brigate Nere, assolutamente volontarie, ma anche l’incorporo nei loro effettivi
di chi, già militando nell’esercito, ne richieda l’assegnamento.
Il successo è strepitoso
al punto che lo Stato Maggiore deve pretendere dal Duce una sospensione
del provvedimento.
Eppure le Brigate Nere non offrono
granché alle ambizioni. Nelle Brigate Nere sono aboliti i gradi
e i fronzoli, vengono accettate soltanto funzioni di comando che sono limitate
nel tempo ed intercambiabili secondo il più autentico socialismo
di trincea. Le Brigate Nere non hanno la copertura istituzionale dell’Esercito
ma sono soggette alla rappresaglia dei futuri tribunali oltre che a quella
partigiana. Quando si milita in esse si fa proprio l’adagio del Cantate
dei Legionari “il mondo sa che la camicia nera s’indossa per combattere
e morir”. Nelle Brigate Nere non vi è futuro né carriera:
eppure tra le loro fila si accorre numerosi anche dalle formazioni dell’esercito
dal quale convergono soldati, ufficiali e persino numerosi colonnelli che
rinunciano ai gradi per una scelta spartiata d’impersonalità guerriera.
Le Brigate Nere sono l’esempio evidente,
corporeo, dello spirito e dell’anima della rivoluzione, cioè della
cultura del pensiero/azione, dell’essenzialità e dell’assialità
anticoromana.
Le Brigate Nere non sono state inventate
da un atto notarile ma sono il frutto di un lungo e cosciente sacrificio.
Caduta Roma, Pavolini si ripromette di non concedere altre rese vergognose
ed organizza la guerriglia fascista. La propaganda ufficiale ci nasconde
le azioni “partigiane” compiute dai fascisti dietro le linee da formazioni
ideate da Pavolini, quali la “Onore e Combattimento”. Di azioni di guerriglia
e sabotaggio, per le quali numerosi saranno i fucilati, ne risultano documentate
diciotto, tra le quali una vera e propria insurrezione popolare contro
la coscrizione nelle fila badogliane nella zona di Catania, la cosiddetta
rivolta dei “Non si parte”. Pavolini organizza inoltre i Franchi Tiratori
che agiranno principalmente a Firenze e a Forlì ma che s’impegneranno
ancora in una decina di città italiane.
Emblematica è la difesa di
Firenze, che il generale americano Alexander disse essere la miglior città
italiana perché “lì - sottolineò - ci accolsero sparando
dai tetti”.
D’altronde quando i Tedeschi avevano
fatto saltare i ponti e rimaneva ancora percorribile un solo passaggio
sull’Arno cercarono di trarre in salvo i tiratori più vicini ma
costoro si rifiutarono dicendo che il loro compito era quello di combattere
fino alla morte.
A Firenze agirono un centinaio di
squadre di tre tiratori, molti dei quali giovanissimi, cui si accompagnava
la distribuzione della propaganda clandestina tramite il foglio “Ventitre
Marzo” il tutto nel rispetto della tecnica di collegamento azione-pensiero
che era prettamente pavoliniana.
Le Brigate Nere nascono, dunque,
nel nome del sacrificio e ottengono con l’esempio di essere impegnate in
prima linea come nelle operazioni di controguerriglia. Pavolini stesso
vi combatte da volontario in Piemonte ed in Val d’Ossola venendo ferito
in prima linea.
Le stesse Ausiliarie delle Brigate
Nere a differenza degli altri corpi ottengono il porto d’armi e possono
combattere.
Tutto l’operato di Pavolini nei
dieci mesi che vanno dalla costituzione delle Brigate Nere alla sua morte,
è scandito da rastrellamenti, riunioni di governo, comizi ed ispezioni.
Egli arringa le Brigate Nere, gli
iscritti al PFR ed il popolo, parlando loro di un Nuovo Ordine Europeo
che deve essere antiplutocratico, poliarchico, etniarchico ed antiborghese.
Ed ecco come le Brigate Nere furono
dipinte da Pavolini:
“Le Brigate Nere sono un esercito
senza galloni essendo noi squadristi persuasi che un comandante è
tale se comanda e gli si ubbidisce e che altrimenti non c’è grado
che tenga. L’unico gallone è l’esempio…
Le Brigate Nere non sono il Partito
che va verso il popolo, sono una milizia di Partito che è popolo,
una milizia operaia e rivoluzionaria, di meccanici, di artigiani, di braccianti,
di piccoli impiegati, in lotta mortale contro le plutocrazie alleate dei
bolscevichi e contro i plutocrati sovvenzionatori di banditi…
Le Brigate Nere anelano al combattimento
contro il nemico esterno ma sanno che in una guerra come l’attuale, guerra
di religione, non c’è vera differenza fra nemico di fuori e di dentro.
Non è lecito chiamare fratricida la lotta contro chi attenta alla
vita e all’onore della Patria. Non è fratello chi rinnega la Madre
e le spara addosso…
Le Brigate Nere in che periodo sono
apparse ? Quando altri si squagliavano e noi ci adunammo. Altri dimettevano
il distintivo e noi ci rimettemmo la camicia nera. Altri cercavano di farsi
dimenticare e noi ci ricordammo. Ci ricordammo delle parole date, delle
fedi promesse, dei compagni perduti. Noi ci ricorderemo sempre…
Le Brigate Nere sono una famiglia,
questa famiglia ha un antenato, lo Squadrismo, un blasone: il sacrificio
di sangue, una genitrice: l’Idea fascista, una guida, un esempio, una dedizione
assoluta ed un affetto supremo: MUSSOLINI”.
Le Brigate Nere furono in linea a
Livorno, Pisa, Buti, Pontedera e misero in fuga, in Garfagnana, gli Americani
della Buffalo.
Dopo il 25 aprile Pavolini tentò
con ogni sforzo di concentrare gli effettivi in Val Tellina per difendere
l’Ultimo Ridotto ma le comunicazioni erano saltate, le strade intasate
ed il progetto di fatto non riuscì. In qualche maniera l’estrema
resistenza, l’estremo sacrificio, furono compiuti dall’insurrezione fascista
delle Brigate Nere di Torino agli ordini del Federale Solaro.
Pavolini, che combatté fino
all’ultimo venne fucilato a Dongo, sul Lago di Como e comandò di
fatto il plotone d’esecuzione. Il racconto forse romanzato degli stessi
partigiani che di lui avevano un’immagine di tutto rilievo ci dice persino
che dopo la prima raffica si rialzasse e tendesse il braccio nel saluto
romano prima di spirare.
Pavolini uomo-mito appartiene alla
storia ma non appartiene al passato.
Innanzitutto perché non fa
parte di un solo tempo chi sia essenziale e coerente, gioioso e cosciente
nel sacrificio. Non è mai superato chi abbia compiuto una rivoluzione
sobria e profonda che ha messo in imbarazzo più gli esteti in camicia
nera, i difensori dell’onore a condizione, i moralisti che vegetano nel
carrierismo e nel capitalismo, che non i suoi diretti avversari d’arme.
In questo e per questo, Pavolini
è ciò che si definisce un archetipo incarnato, lo stesso
archetipo di Catilina, di Giovanna d’Arco o di Ernesto Guevara detto il
Che.
Rispetto ai quali, tutti, che insieme
furono fustigatori degli uomini a metà, che smascherarono gli apostati,
gli accomodanti e gli arrivisti, egli ha un di più: uomo di lettere,
di cultura, di prestigiose frequentazioni, è la prova di come l’intransigenza
verso di sé e l’intelligenza realistica non siano tra loro contrastanti
se non nella mistificazione che ci offre l’ideologia borghese.
Ma l’attualità di Pavolini
va anche oltre quest’atemporalità della figura.
Nel mondo che oggi viene definito
“globale” le misure di partecipazione, di democrazia diretta, di autonomia
piena, sociale e guerriera che son proprie del modello pavoliniano si dimostrano
antesignane rispetto ad una tendenza di autonomia, di localizzazione e
di superamento del capitalismo finanziario e speculativo, in un modello
attivo imperniato sulla logica del matrimonio luogo-lavoro e sul recupero
dell’essenziale e del solidale.
La concezione pavoliniana di Nuovo
Ordine Europeo, la sua denuncia nei confronti di tutte le internazionali,
finanziarie, politiche e religiose, preannuncia una visione europea, imperiale
che, proprio in quanto si fonda sulle autonomie partecipative locali, prospetta
un’alternativa ghibellina alla macina mondialista.
Pavolini è dunque oggi, come
per sua volontà, passato, presente e futuro.
Pavolini lo è per chi sappia
coglierne l’esempio ed il monito, l’insegnamento e lo sprone, per chi sappia
rinunciare ai fronzoli, ai galloni, al narcisismo, al vacuo amor di sé,
alla carriera, alla riuscita sociale, ai mille e mille alibi che si trovano
sempre per disertare le responsabilità onerose.
Per chi, in altre parole, sappia
essere esempio e, soprattutto, sappia pagarne il costo.
“Un’Idea vive nella sua pienezza
e si collauda nella sua profondità quando il morire battendosi per
essa non è metaforico giuramento ma pratica quotidiana”.
Parole secche, prive di retorica
perché già pregne di lucido pathos; non parole al vento,
perché dette da colui che rese usuale, quotidiano, normale, il gioioso
martirio di stampo squadrista, perché pronunciate da colui che avrebbe
combattuto fino all’ultima cartuccia, che avrebbe creduto al Ridotto della
Valtellina - le famose Termopili del Fascismo - e avrebbe infine comandato
di fatto il suo stesso plotone d’esecuzione.
Questo, signori, è Pavolini
e fermiamoci qui. Chi ha orecchie per udire ascolti, chi ha vene nei polsi,
vibri, chi ha cuore e intelletto apprenda e metta in atto. |